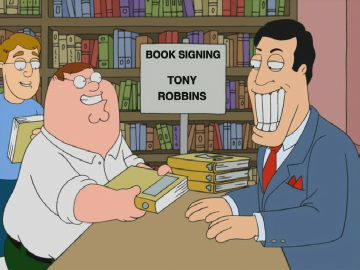Secondo piano, ambulatori di chirurgia. Una donna con i capelli sale e pepe appoggia la mano sulla spalla della figlia appena adolescente. «Chiediamo!» propone e la ragazza, silenziosissima, la segue sino a metà corridoio.
Bussa a una porta. Quella si apre e mostra la testa di un’infermiera, quasi le fosse stata mozzata dal collo.
«Scusi, mia figlia deve fare una visita pre-operatoria. Lascio nome e cognome a lei?»
«Se ha appuntamento, è già nella lista, signora. Accomodatevi pure nella sala d’aspetto qui accanto. Vi chiamiamo noi.»
Ottimo. Ho avuto le informazioni che mi servivano senza usurare le corde vocali. Seguo la Signora Salepepe e la Ragazzina Silente. Su una delle sedie c’è già un uomo calvo e con gli occhiali. Altri due posti sono occupati da un padre e un figlio adulto. Entrambi dotati di caviglia dal dondolìo facile. Il loro senso del ritmo fa traballare tutta la fila di seggioline, inclusa quella sulla quale, malauguratamente, ho posteggiato le mie terga.
Avrei avuto appuntamento alle otto e dieci. Alle otto e mezza sono ancora alla mercè dei Dondolatori. Nel frattempo, entrano un signore brizzolato con il giornale sotto braccio, un giovanotto corpulento con il dito attaccato ai tasti del cellulare, un tizio sulla sessantina alto quanto un lampione, con lunghi capelli da capo Sioux raccolti in una coda di cavallo, un ometto tondo insaccato in una felpa verde smeraldo e una coppia di anziani. La vecchietta sembra una persona cordiale; il marito neanche un po’. Ha gli occhi iniettati di sangue e una smorfia arcigna appesa tra il naso e la sottile linea delle labbra. Magari ha quegli occhi perché deve farsi operare di cataratta - penso - quindi non è opportuno trarre conclusioni lombrosiane a caso.
Finalmente l’infermiera Decollata, recuperato il proprio tronco, si presenta nella sala d’aspetto e rapisce il Calvo Occhialuto. Pochi minuti dopo l’uomo esce dalla stanza della Decollata, saluta gli astanti, raccatta un berretto rosso dall’appendiabiti e se ne va.
Sono le otto e quaranta. Decollata torna a pesca nel nostro lago.
«Chi c’è, adesso?»
«Tóca a mi!», chiarisce l’Iniettato, a gomiti larghi.
Mi viene un dubbio. Avevo sentito Salepepe ricevere una telefonata. Parlava in tedesco. Forse non conosce troppo bene, le italiche dinamiche...
«Un secondo!», esordisco, «Ma che ordine state seguendo?»
«Chi è arrivato, prima?» dice Decollata.
«No, un momento: quindi vige il Chi-prima-arriva-meglio-alloggia, o avete una lista con gli appuntamenti, in ordine di orario?»
Decollata è perplessa fin quasi allo smarrimento.
«Intendo: io, per esempio, sono stata convocata alle otto e dieci... Lei, signore?»
«Otto e venti. Questo mi hanno detto, per lo meno, quando mi hanno telefonato» replica Brizzolato Lettore.
«Io, otto e mezza» dicono, quasi all’unisono, Insaccato Verde e Lampione Sioux.
«Lei a che ora aveva appuntamento?» fa Decollata a Iniettato.
«Mi? Ae òto e quaranta. E xé e òto e tre quarti.»
«E lei, signora?» chiedo a Salepepe Tedesca.
«Veramente, avevamo appuntamento alle otto.»
«Bene,» chiudo io «allora tocca alla signora e alla signorina, poi a me, poi a questo signore qui e poi ai due delle otto e trenta. E Il ragazzo, laggiù?»
«Alle nove. Io aspetto.»
Iniettato mi odia. Aveva già un piede dentro la stanza di Decollata e, in un secondo, è stato retrocesso al sesto posto a causa mia. Salepepe, invece, mi sorride. Ragazzina Silente mi ringrazia, un secondo prima che sua madre chiosi «Per fortuna che c’è ancora qualcuno, qui, che...» e sparisca dietro la porta con l’infermiera.
La moglie di Iniettato capisce l’antifona e torna a sedersi nella sala d’attesa. Lui no. È stoico. Si piazza nel corridoio, ignorando cocciutamente i cartelli con su scritto “Transito barelle. Vietato ingombrare il passaggio”.
Io mi metto sulla porta, a due passi da lui. Penso che potrà essere anziano, operabile, prepotente e iniettato quanto gli pare, ma se vuole fregare il posto a me o a uno degli altri cinque prima di lui, dovrà passare sul mio cadavere.
Madre e figlia escono, ringraziandomi di nuovo. Iniettato si stacca dal muro, pronto a raggiungere la meta.
«Adesso, tocca a?» trilla Decollata.
«A me, eccomi.» rispondo, con un tono che non ammette repliche, il passo lungo e ben disteso, le spalle dritte come se, nel giaccone, avessi scordato una gruccia.
Iniettato borbotta. E borbotti pure, per quel che m’importa!
Decollata mi mostra un paio di fogli con le indicazioni per le prossime visite. Mi fa un prelievo del sangue, ritira il campione di urina.
«Ok. Quindi adesso vado a fare l’elettrocardiogramma, poi, nel pomeriggio, torno per la visita con l’anestesista?»
«Sì, esatto, e...»
Si apre la porta. È un’altra infermiera, bassina, castana, con le guance rosse.
«Vuoi sapere l’ultima? Non posso andare in ferie!» strilla a Decollata.
«E perché?»
«Mi ha detto che, da domani, va così. Va così e basta, mi ha detto. Capito?! Così e basta!»
Guance Rosse s’infervora, gesticola, sbatte oggetti sconosciuti a destra e a manca. Decollata, solidale, annuisce e sgrana gli occhi a cadenza regolare.
«Scusate...», dico io «devo fare altro, qui? Devo firmare qualcosa?»
«No, ha finito. Vada pure.» dice Decollata.
«Ah, mi scusi!»
«Prego?»
«Dopo di me, tocca al signore brizzolato, con il giornale sotto braccio.»
«Perfetto, grazie. Arrivederci.»
Recupero l’ombrello dalla sala d’aspetto, saluto vecchie conoscenze e nuovi arrivi, ignoro bellamente Iniettato e consorte e scendo a piano terra.
Ho, colpevolmente, ignorato dell’altro, ma non ne sono ancora consapevole.
All’ambulatorio di cardiologia, mi consegnano un tagliandino bianco con il numero 11. Prima di me c’è solo un tizio di una magrezza imbarazzante. Gli altri hanno biglietti di altri colori, quindi non fanno testo.
Passati cinque minuti, si apre la porta di colpo e, alla chetichella, entrano Iniettato e la moglie. Consegnano loro il 12 bianco e io, dopo un sacrosanto “Eccheccacchio, è ‘na persecuzione!”, me la rido sotto i baffi: entreranno, di nuovo, dopo di me.
Fatto l’esame, abbandono l’ambulatorio. E pace ai vivi, anche a quelli con il sangue negli occhi.
Con gli stivali di gomma ai piedi, raggiungo l’approdo. Il mio battello parte tra pochi minuti.
Rientrata a casa, mi taglio due fette di formaggio e preparo un’insalata di pomodori. Appena mi siedo a tavola, squilla il telefono.
«La signora F.?»
«Sì, sono io. Con chi parlo?»
«È la chirurgia del civile... scusi, ma lei non è più tornata su, per l'anamnesi!»
«Eh? Ma se mi avete dato appuntamento alle 15.20?!»
«Ma quella visita è con l'anestesista! L'anamnesi la fa il chirurgo!»
«Buono a sapersi, ma non me l'avevate detto!»
«Sì che gliel'ho detto! È colpa sua!»
«Col..? Va be', magari non ci siamo capite.»
«Io gliel’ho detto!»
«Guardi, come le pare... e quindi, che posso fare adesso?»
«Deve tornare martedì prossimo, sulle nove e mezza- dieci.»
«COOOMEEE? Ma non posso vedere il chirurgo oggi visto che, nonostante l’acqua alta, il diluvio universale e l’ora di attesa già buttata stamattina, mi fate tornare lì?»
«No, il chirurgo c'è solo il martedì.»
«Ehm... e oggi, secondo lei, che giorno sarebbe?»
«Intendevo martedì mattina.»
«Non è che lei sia un po’ troppo ermetica?»
«Prego?»
«Niente, pensavo ad alta voce... Mi faccia solo capire una cosa: spostando l’anamnesi al prossimo martedì, anche l'intervento slitterà di una settimana, giusto?»
«È probabile.»
«Benissimo! Sono quasi due mesi, che vi corro dietro, lo sa? Il centro prenotazioni non prenota, il chirurgo sparisce, il centralino risponde - Embe’, da me cosa vuole sapere? - se lo si contatta per capire chi chiamare... ma non importa. Se dovessi avere altri problemi, tra oggi e il prossimo martedì, tornerò al pronto soccorso. Lì sono stati veloci, precisi e gentili. Certo, mi hanno detto - testuali parole - che ho un intestino orrendo, ma mica dipende da loro, no?! Me ne farò una ragione!»
«Guardi, non so cosa dirle,. È lei che...»
«Grazie per avermi avvisato. Buona giornata, infermiera.»
L’interruzione dell’altra infermiera, dopo il prelievo, l’aveva distratta. E aveva distratto anche me.
È convinta sul serio, di avermi detto del chirurgo. Può capitare, per carità. Però mi auguro comunque che Guance Rosse e Decollata non vedano ferie fino al 2042.
Fatta la visita con l’anestesista, con Il Piccolo a manina, ho fatto un raid a chirurgia. Ero a caccia del chirurgo. A un certo punto, credo di incrociarlo. Cerca di entrare nella stanza di Decollata! Non sono sicura al cento per cento, che sia lui. Ancora titubante, perdo l’attimo fuggente: il dottore mi scappa sotto al naso. Ma sono fortunata. Era andato a recuperare le chiavi della sala prelievi, quindi torna sul luogo del delitto. Mi decido, dunque:
«Scusi... lei è il dottor L.?»
«Sì, sono io.»
«Io sono quella che, stamane, non ha fatto l’anamnesi, per un disguido... potrei chiederle di farla adesso, invece che tornare qui la settimana prossima?»
«Gliela farei, se non avessi molte altre cose da fare, in questo momento.»
«Quindi... a martedì prossimo?»
«Yesss!»
Ha fatto pure il simpatico, ha fatto! Il simpatico anglofono, per giunta.
Quasi quasi crepo dalle risate.
Be’, magari crepo e basta, chi lo sa? Sarebbe un bel gesto, per tutti gli Iniettati che ho incontrato sulla via.