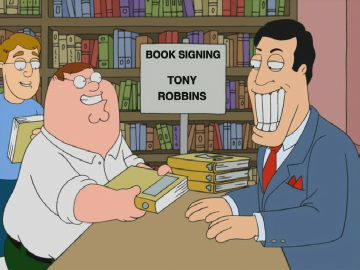Molto prima di Forrest Gump, prima di “stupido è, chi lo stupido fa” e di “sono un po’ stanchino”, io correvo. Era il 1986 e lo Squadrone della quinta elementare era composto quasi esclusivamente da maschi. Quasi. Non avevo leziose trecciuole infiocchettate, né gonne plissettate, né camicie rosa a far capolino da sotto il grembiule inamidato. Io, il grembiule, non lo mettevo mai. Finiva appallottolato nella cartella un minuto dopo il trillo della campanella d’ingresso.
A ricreazione, mentre le femmine - glauche, acconciate e ricamate - giocavano a mamma-casetta sotto il pesco, lo Squadrone guadagnava il margine del cortile, pronto a tagliare l’asfalto a tutta velocità. C’erano Carlo, Mario e Sandro; qualche volta Davide, Stefano ed Emanuele. Andrea era troppo alto, ma ci provava lo stesso. E poi c’ero io. Pantaloni da battaglia, il muso di Topolino sulla T-shirt, zazzera appena sopra gli orecchi e scarpe da ginnastica. Grigie e con lo ssstrap, Così, se serve, te le togli in un secondo, diceva mio padre. All’immaginario nastro di partenza eravamo tutti uguali. Magri-grassi-alti-bassi-pallidi-scuri-timidi-spaccamondo.
E maschi. E una femmina che sapeva arrampicarsi sugli alberi.
Poi qualcuno fischiava e la corsa aveva inizio. Si arriva fino alla rete verde e si torna indietro: il primo che tocca questa macchia a forma di patata, vince la gara!
Mandria di piccoli bisonti. Scalpiccio. Fiatoni. Grida guerriere.
Io non riuscivo a tenere ferma la lingua. La spostavo freneticamente da sinistra a destra e viceversa, tra le labbra a fessura. Forse il mio motore era lì. Corri!, ripetevo, Corri e non pensare a niente. Non alla milza dolente, non alla gola asciutta, non al calzino con il buco che strozza l’alluce, non al compagno che sta gridando Cavoli! Va come Mennea!
Raggiunta la chiazzapatata, in debito d’ossigeno, finivo puntualmente sulle ginocchia.
Non vincevo sempre e poco m’importava. Quelli, erano i migliori diecimetristi da Squadrone dell’universo. Perché non si limitavano a includermi nel branco con tutta la naturalezza della bonomia infantile; grazie a loro era gioia allo stato brado, quella che risaliva dai polpacci agli zigomi.
Credo non lo abbiano mai capito, i ragazzi, quanto mi facessero sentire dio, quando mi chiamavano Pietro.