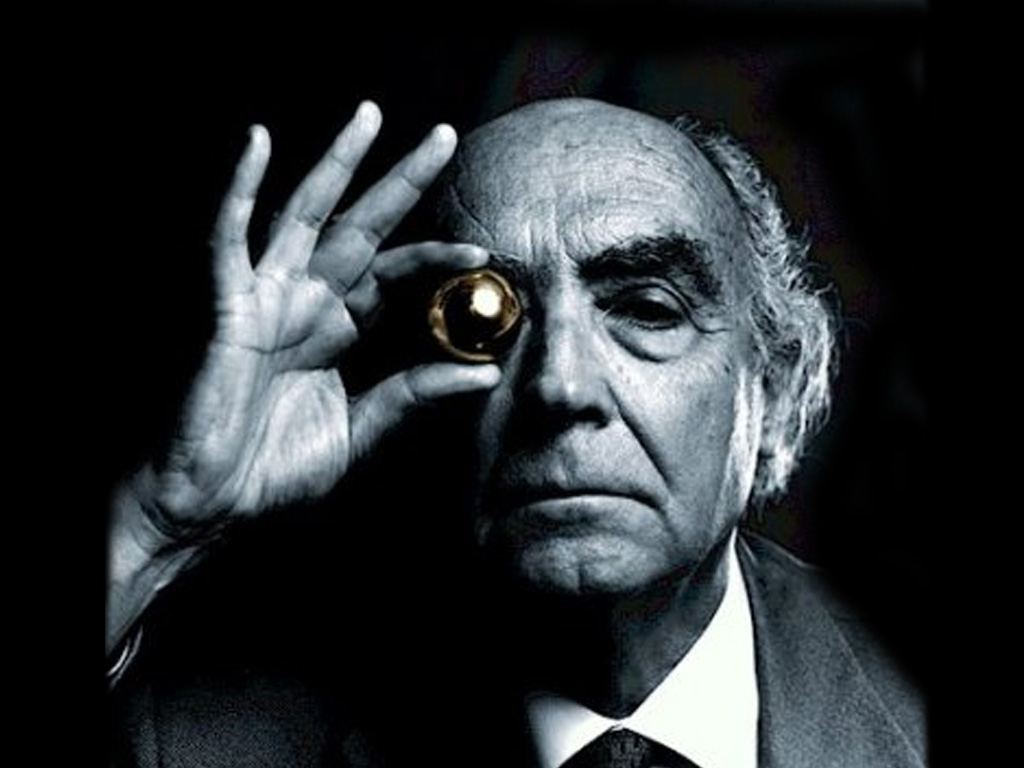La riva da percorrere è inondata da un sole sfacciato. Ne calpesto il selciato mentre vado da qui all’asilo. Ve lo dico subito, risparmiate l’ironia: vado a prendere mio figlio; io, dal tunnel (quello di cemento armato, con l’arcobaleno di vernice anti-pioggia), sono uscita oltre trent’anni fa.
È inesorabilmente marzo. Me ne accorgo perché si compie, puntuale, un rito conosciuto. Con la primavera i bruchi abbandonano l’abito bolso e sfidano il cielo.
Sono uscita prima delle tre e mezza, oggi. I tacchi, bassi, sonori e comodi, borbottavano il loro tlock-tlock in un silenzio rotondo, profumato, brillante. Dal muro, si è staccata la prima: ali frastagliate orlate di nero, di un arancione carico appena ammorbidito da radi pois scuri. È sbucata da dietro la schiena volando alla mia sinistra, mi ha tagliato la strada, si è appoggiata di nuovo sulle pareti esterne del palazzo alla mia destra. Qualche metro più avanti, ecco la seconda. Uguale all’altra. Stessi colori, stessa grazia, stesso schema danzante. Quando la linea delle abitazioni si è interrotta, lasciando spazio all’arioso slargo prima del solito ponte, la coppia volante ha cambiato strategia: un perfetto otto (o sarà stato un fiato d’infinito?), con il mio metro e settanta d’ossa prima in questo cerchio, poi in quello, poi in questo, poi in quello... roba da far impallidire persino i cinguettanti pennuti di Biancaneve.
Se riuscissi a concentrarmi sulle splendide ali, escludendo dalla mente il fatto che siano appiccicate a orribili, mostruosi, bavosi insetti, quelle due farfalle mi tornerebbero un sacco simpatiche. E magari, invece che polverizzare il record dei 1500 metri piani in fuga dal raid, potrei addirittura improvvisare un soave canto disneyano, alla faccia di quella sciacquetta, principessa animalista dei miei stivali.